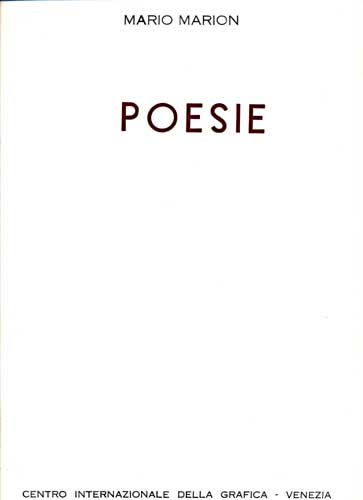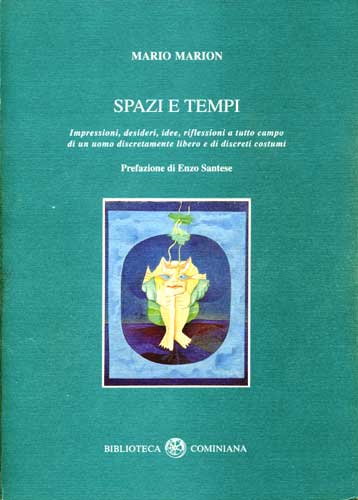Graziella
(1951) - Poemetto trecentesco
I
Vidi
la luce tua su l'altre mille
lì, tra nubi, in ciel icona stavi
e negl'illuni spir mirato fille.
Era
sera, quando da lochi pravi
m'incamminai a l'erto col fatale,
tra sentier mi persi e tronchi gravi.
Come
m'appar lo Deo giammai mi cale.
Gracil, cereo, d'orma era gentile
pur co' l'occhi voti d'umor ferale.
"
Egro mortal - di' -, qual agno ovile,
tu vai cercando donna c'ha morbato,
or vien meco, ch'io son 'l busto virile
Che
sì ben figura sullo stilobato
ch'l fondo 'dorna de la dimora l'atrio
dove si sta 'l personaggio amato.
Vien
tra color ch'han perduto il patrio
sospir del core dei verd'anni belli,
vien tra color cui fe' d'amore strazio.
Li
troverai diva ch'ognor anelli.
Quanto sia grande lei vedrai o uomo.
Lei cui Lui plasmò dai pie' ai capelli.
Il
bianco spettro disse, e fui domo.
Quel che m'avvenne poi non so pur dire
che le froge colò, del capo, 'l duomo.
II
Stelle,
fochi parvon l'etra vestire
nel volitar col bellurioso manto
sì ch'in prato son fior ne lo fiorire.
E
qual candor ne l'armonioso canto
infondon st'aer, che de 'l viver spoglio
creò l'amor, del sol amor il pianto!
Oh,
pur lo Deo si dipartì dal scoglio
ch'è l'antro del petto ch'a st'aedo trista
sì ch'io negletto mi trovai nel doglio.
E
qual stuolo fin la perduta vista
m'avvolgon l'ombre ch'io giammai vedetti
e quell'ir convulso vieppiù m'attrista.
Bianco
il color, blavi gli aspetti
ei s'involan verso le luci fise
vengon, s'en van, nel lacrimar dei petti.
S'alzan
veli che l'amore uccise
per gli bagliori che mai più ristanno
quali miraggi, a peregrin rise.
Quel
tal fattor, quell'infausto affanno
cui di costor degl' automi ha fatto
colto ha di già, del mio cor, lo scranno.
Poi
che su, più su, nell'eccelso tratto
aurea s'accese 'l mio amor corona
sì ch'in la schiera di color, son ratto.
III
Diva,
al tuo fulgor l'estro si prona
ché tu sei tutto, io meschino fui,
parvo, ch'amor desiò di sì matrona.
Nel
vorticar de li barbagli sui
che da la cima del più alto cielo
vividi imperan ogn'orma altrui…
Tutto
si fuse l'astruso impero.
Solingo stetti, nel diafano busto,
egro mirai quell'arcan ch'anelo.
Tal
qual mortal che del sol il venusto
vole guatare e v'ha l'occhio leso,
lesto 'l distolsi a l'amaro gusto.
Ma
quell'ardor ch' à l'amore acceso
via mi portò fin quell'eterea meta
nerbo m'infuse, spranzoso asceso.
Niveo
aliger per l'ermo pianeta
fioco mi persi ne l' spazi astrali.
Alma turbina 'gnor l'alta cometa.
Tutt'aere
si tinse de' rai fatali,
di quella Luce che con la mia speme
lungi s'en iva per più grandi strali.
Po'
quel richiamo che dal mister viene
tutto svolse, a me tutto distrusse…
Era il richiamo ch 'l mister tiene.
IV
Quaggiù
ristetti e a ciò che fusse
mesto pensando, in l'atro alone
l'occhio riporsi: ohi, com'ei rilusse.
Quando
s'avvide che l'alta magione
tutt'irrorata era dei rai di Lei,
sì che di notte dì facea stagione.
Fulgid'effigie
de li sogni bei,
ea fatt'ombra era segnata presso
a la Cima che ne li giorni mei
tutti
appellan nel Paradis v'esso.
E sì era magna, sì era fiera.
O peccator! salir volli, io desso.
E
Lui chin a Lei pian piano diceva
quelle parole che sol Lei comprende.
Io, piccol mortal, ch' imperador era.
Io
son figliol di quel Giudà che vende,
Ea è pupilla del più gran Fattor,
Ea è la fata che più su risplende.
Ma
perché il Giusto me nutrì d'amor
per ella Grazia ch' in l'eter s'asside,
ma perché m'afflisse di sì gran dolor?
Che
nel rocar cui da 'sto petto stride
m'ergo pensoso, l'Ineffabil viro…
Ché mai sapro 'bliar chi 'l sen m'occide.
Quest'è,
lettor, del malo mal nimico
storia, cui, con celate verba, dico.